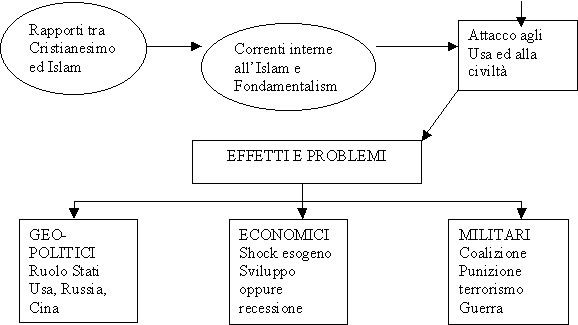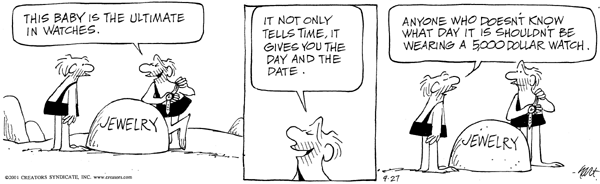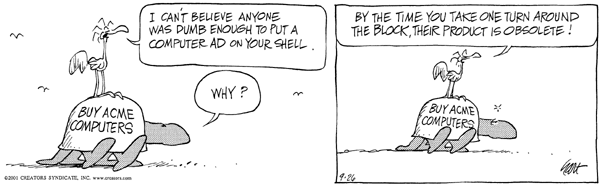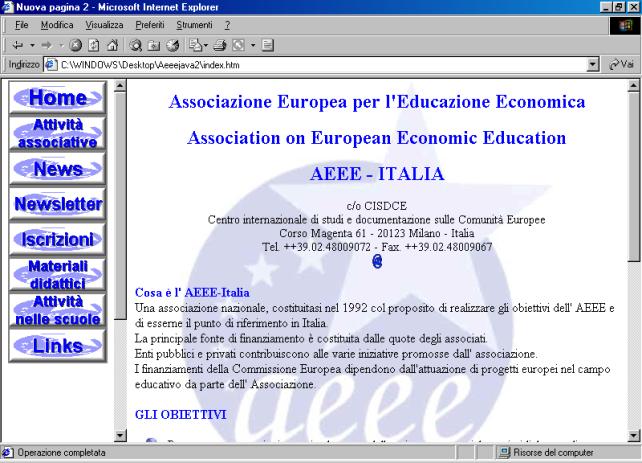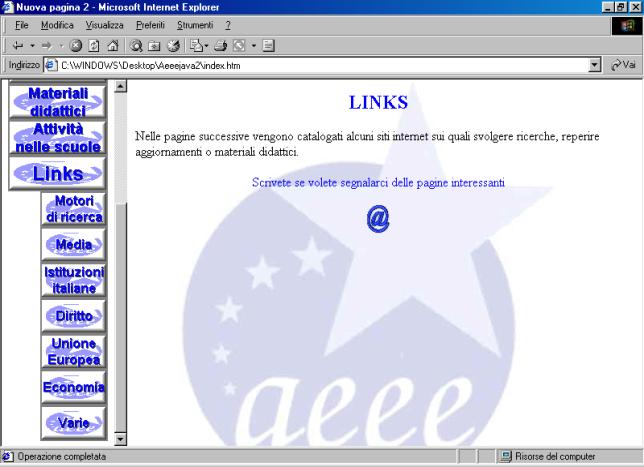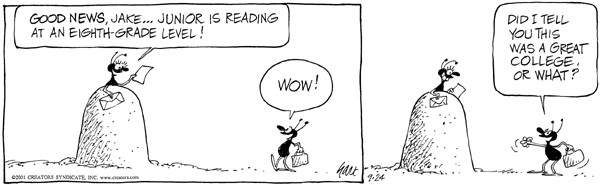|
|
ASSOCIATION
OF
EUROPEAN
ECONOMICS
EDUCATION
|
ASSOCIAZIONE
EUROPEA PER
L’EDUCAZIONE
ECONOMICA
ITALIA
|
Newsletter della Sezione
Italiana – Anno VIII –
Numero 18 – Ottobre 2001
coordinamento: sergio zangirolami
impaginazione: teresa dal maschio
Sommario
1.
La
tragedia
americana
di Enrico Castrovilli pag. 1
2.
Incertezza
e rischio:
la XIII^ Conferenza AEEE in Università Bocconi di Elide Sorrenti pag.
3
3.
Inchiesta
sull’incertezza nelle rappresentazioni sociali dei giovani europei di
Doris Valente pag. 5
4.
New
Economy
e old economics? di
Roberto Fini pag.
8
5.
Apriamo un
forum
di discussione: Dove vanno le discipline economiche aziendali e
giuridiche?
Intervento
di Elide Sorrenti pag. 11
Intervento
di Sergio Zangirolami pag. 12
6.
Nuovo
sito
dell’AEEE-Italia di Giuseppe Tramontana pag. 14
7.
XIV
Conferenza
dell'Associa-zione Europea di Educazione Economica (AEEE)
di
Doris Valente pag 16
8.
Recensioni di Sergio Zangirolami pag. 17
9.
La
didattica modulare nella materie economiche aziendali e giuridiche
di Lidia Colombo – Diana Collu – Marco Spriano
pag. 20
10.
Scheda
di iscrizione AEEE-Italia pag. 20
1.
La tragedia americana
di Enrico Castrovilli
Come affrontare didatticamente la tragedia che si è
abbattuta sugli Stati Uniti d'America l'11 di settembre di quest'anno? In
moltissime classi della scuola dell'obbligo e delle superiori si è discusso
ampiamente con gli allievi. In queste occasioni si sono intrecciate
valutazioni, informazioni, preoccupazioni. Gli spunti usciti dalle discussioni
sono stati ripresi dai docenti, che hanno utilizzato i contenuti e gli
approcci provenienti da discipline molto diverse, storia, religione,
geografia, diritto, economia, letteratura ed altro ancora. Naturalmente la
cronaca ha fatto la parte del leone, come era giusto che fosse sull'onda
dell'emozione causata dal colpo inferto agli Stati Uniti d'America. E non solo
ad essi.
Come strutturare un percorso didattico più organico,
che saldi la drammatica urgenza della cronaca con la crescita delle capacità
di comprensione e con la maturazione degli allievi?
Un percorso potrebbe svilupparsi in queste fasi:
1. Raccolta e
analisi delle informazioni.
Questa prima fase deve innanzitutto mettere a fuoco
le informazioni indispensabili per capire i fatti. Le informazioni possono
essere contenute nella propria memoria, su quotidiani, televisione, radio,
Internet, riviste, possono nascere da discussioni con amici e parenti.
Questa fase va realizzata con cura e deve spingersi
nella profondità che l'età degli allievi consente. Nel triennio di una
scuola secondaria superiore le informazioni basilari da raccogliere nella
prima settimana dopo l'11 di settembre potevano ad esempio riguardare:
· I morti, i danni, i soccorsi
· Le tecniche di dirottamento e i tipi di aerei
dirottati
· Cosa erano le Twin Towers a New York e cos'è il
Pentagono a Washington
· Cos'è la globalizzazione
· Il fondamentalismo religioso
· Il terrorismo internazionale
· Le reazioni dell'opinione pubblica nelle diverse
parti del mondo
· Il ruolo degli Stati e degli organismi
internazionali quali la Nato, l'Onu, l'Ue.
Le informazioni devono essere ricercate, analizzate,
confrontate. Anche oltre la durata di questa prima fase va evidentemente
tenuta aperta una finestra per la raccolta delle informazioni successive.
Ruolo del
docente:
· aiutare nella raccolta delle informazioni
· indicare fonti giornalistiche o di altro tipo.
Numerosi articoli di peso sono apparsi, a parere di chi scrive, su Il Corriere
della Sera, La Repubblica, Il sole 24 ore, Il Foglio.
· aiutare, se richiesto, nella comprensione ed
analisi delle informazioni
2. Stesura di
una prima mappa mentale
La mappa mentale è una tecnica didattica semplice ed
essenziale. Ogni allievo da solo o in piccoli gruppi deve redigere la propria
mappa, evidenziando le gerarchie logiche dei fatti (relazioni di
causa-effetto, relazioni di azione e reazione, relazioni indeterminate e così
via) ed il tipo di connessioni che li legano.
La mappa può essere costruita evidenziando nei
blocchi concettuali le cause profonde dei fatti, le cause prossime, le
conseguenze immediate, le prospettive che si possono sviluppare.
Le mappe sono molto utili perché mostrano come
ragionano le teste delle diverse persone e come esse utilizzano le conoscenze
di cui dispongono.
Le mappe vanno quindi presentate, discusse e valutate
tra tutti gli allievi.
Ruolo del
docente:
· definire
che cosa è una mappa concettuale
· chiarire il procedimento di stesura di una mappa
mentale o concettuale
· aiutare
gli allievi nelle proprie presentazioni
· presentare anche la propria mappa mentale, un
esempio ne è "Il terrorismo nell'era della globalizzazione" (per
semplicità in questa mappa sono solo indicate le gerarchie logiche tra i nodi
concettuali e non il tipo di connessione che li collega)
· far
emergere le differenze tra le diverse mappe
3. Gli
approfondimenti
La discussione delle mappe riesce a far emergere i
punti meritevoli di particolare approfondimento perché costituiscono i
fatti/aspetti storici/teorie dotati di una maggiore forza causale, perché
disvelano i punti più aperti e problematici, dove le idee e le
interpretazioni possono e debbono divergere fino eventualmente a contrapporsi.
IL
TERRORISMO NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE
|
VANTAGGI GLOBALIZZAZIONE
|
FORZA E LIMITI DELL’OCCIDENTE
Tolleranza, Suffragio universale, Sperimentazione
scientifica.
Ma anche relativismo etico |
SVANTAGGI GLOBALIZZAZIONE
Perdita propria identità
|
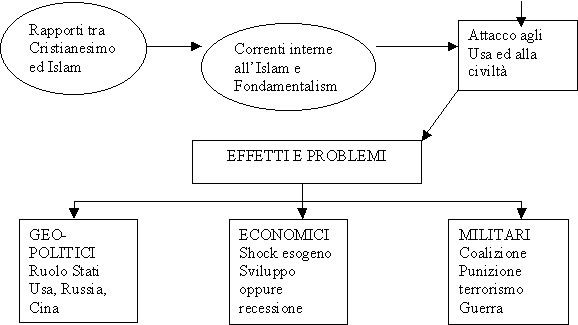
Una selezione di punti
problematici individuati dagli allievi di classi quarte e quinte della scuola
di chi scrive è ad esempio la seguente:
· La cause dell'attacco agli
Usa
· Cause e conseguenze
immediate dell'attacco agli Usa
· Il terrorismo e l'odio
anti-americano
· Il mondo islamico
· La donne nell'Islam
· La storia della Palestina
· I gruppi terroristici
suicidi
· Sì o no all'uso della
forza
· Le conseguenze economiche
dell'attacco
· Come tornare alla normalità
· Aspetti militari
Questi approfondimenti possono
essere presentati e discussi a tutti gli studenti della classe. Questa attività
consente di evidenziare le capacità espositive, la coerenza logica, le
capacità argomentative degli studenti.
Ruolo del docente:
· Fornire una bussola per la
ricerca di materiali di approfondimenti
· Selezionare e distribuire
materiali indispensabili. Tra gli interventi e le pubblicazioni di maggior
peso vale la pena segnalare:
"Dai una possibilità
alla pace" di Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo, www.francarame.it del
13/9/2001
"La rabbia e l'orgoglio" di Oriana Fallaci,
Corriere della sera, 29/11/2001
"La vera arma contro i
tiranni del terrore" di Salman Rushdi, La Repubblica 3/10/2001
"La guerra del
terrore" Quaderno speciale di liMes, supplemento al N. 4/2001, Gruppo
editoriale l'Espresso
"La prima guerra
globale" GlobalFP, La Stampa, Iai, Ispi, N.11 Ottobre 2001
4. Una ridefinizione concettuale
Al termine del percorso è
interessante verificare se gli allievi hanno acquisito una diversa percezione
del problema, tramite la stesura di una mappa concettuale conclusiva,
rappresentativa delle posizioni di tutti gli studenti e di tutti gli
approfondimenti svolti. La mappa può anche individuare i punti problematici,
su cui la riflessione potrà continuare.
sommario
* * *
2.
Incertezza e rischio:
la XIII^ Conferenza AEEE in Università Bocconi
di Elide Sorrenti
La
13° Conferenza dell'AEEE, organizzata dall'AEEE - Italia, ha avuto luogo dal
30 agosto al 3 settembre 2000 a Milano presso l'Università Bocconi. Tema
proposto: "UNCERTAINTY AND RISK
The role of economics and business education: European Union and global
context". Hanno
partecipato 94 persone
provenienti dai diversi paesi europei. In prevalenza docenti medio-superiori e
universitari di discipline giuridico-economiche, direttori di istituti
scolastici e ricercatori e uomini di affari. La composizione quantitativa in
base alla provenienza è stata la seguente:
Danimarca (20), Italia (19), Germania (14), Regno Unito (7), Svezia (6),
Irlanda (6), Belgio (5), Paesi Bassi (5), Francia (4), Grecia (3), Lussemburgo
(2), Spagna (2), Malta (1).
Il
tema dell'incertezza e del rischio nella pratica e nella teoria economica ha
rappresentato il punto focale di tutto il progetto. L'incertezza, sempre
presente nelle vicende umane, assume particolare rilievo in questo momento
storico. Il diffondersi delle nuove tecnologie dell'informazione e il
conseguente superamento delle barriere spazio-temporali sembrano non porre
limiti alla crescita di relazioni tra soggetti non presenti fisicamente tra di
loro. I flussi di informazioni, transazioni e decisioni, che ne derivano, pur
spesso con caratteri di estrema
volatilità, hanno un forte impatto nei sistemi sociali, sia a livello
politico-economico, sia sugli stili di vita. Ne derivano situazioni, in cui
l'orizzonte temporale delle proprie scelte diviene ad un tempo più ricco di
opportunità e meno chiaro. Nella scelta del tema e nell'organizzazione dei
lavori della Conferenza è stata
assunta questa ipotesi:
l'incertezza come categoria del pensiero può influenzare i paradigmi teorici,
le pratiche economiche e, con riferimento all'educazione e all'orientamento
dei giovani, la loro scala di valori.
Gli
obiettivi ed i risultati del progetto hanno riguardato:
a) l'ambito
teorico: esplorare
se e fino a che punto le teorie economiche hanno assunto la
categoria dell'incertezza per metterne a fuoco l'influenza su comportamenti
ipotizzati di produttori, consumatori e di operatori pubblici.
I
relatori presenti alla Conferenza hanno sottolineato:
-
l'evoluzione più recente delle teorie economiche come progressivo approccio
al tema dell'incertezza;
-
l'influenza del passato e del futuro, le aspettative individuali, l'importanza
del passato sulla politica economia, l'incertezza come stimolo
all'autodisciplina e alla cooperazione, gli ultimi modelli di comportamenti
strategici delle imprese ed il
ruolo dello Stato.
L'introduzione
della categoria dell'incertezza negli schemi
teorici dell'economia e delle scienze sociali, la diversa
configurazione degli Stati in una dimensione europea e globale, caratterizzata
dal formarsi di istituzioni sopranazionali e dalla presenza dominante delle
nuove tecnologie della comunicazione hanno
suggerito, durante il corso dei lavori, innovazioni negli obiettivi
cognitivi, nei metodi di insegnamento, nei problemi da esplorare e nei valori
da proporre in merito allo studio di queste discipline. Per affrontare la
complessità dello scenario socio-economico attuale, da un punto di vista
cognitivo, è emersa l'esigenza di assumere, quale concetto chiave,
l'interdipendenza perché può
esprimere rapporti, che si condizionano reciprocamente.
Con questo strumento è possibile favorire una
formazione integrata costituita da competenze,
basate su:
a) capacità di
correlare e analizzare fenomeni,
b)
abilità operative in merito all'uso del calcolo numerico anche con strumenti
informatici;
c)
capacità di connettere in un quadro coerente
variabili e grandezze
d)
attitudini ad affrontare ambiti nuovi usando le conoscenze già acquisite;
e)
attitudini ad apprendere altre conoscenze.
b)
l'ambito
pedagogico: verificare il ruolo formativo ed orientativo dell'insegnamento
economico, avendo presenti il contesto attuale e le più recenti teorie.
Viene
assunto un modello scolastico basato sulla centralità
dello studente, l'enfasi è posta sul
processo di apprendimento. L'epistemologia su cui si basa il quadro
formativo proposto e, in molti casi già operativo, è quella costruttivista.
L'insegnante ha il compito di aiutare gli studenti, attraverso l'uso
di metodologie di tipo euristico, a far evolvere in conoscenze
scolastiche (scientifiche) i loro saperi naturali relativi al contesto
sociale, economico e giuridico, costituiti
principalmente da opinioni, credenze, attitudini. Si favorisce in questo modo
la costruzione del loro sapere attraverso lo studio delle discipline
economiche e giuridiche. Il punto di partenza per avviare un positivo processo
di apprendimento è la
valorizzazione delle loro rappresentazioni spontanee, più o meno strutturate,
dei fenomeni sociali.
Secondo
il punto di vista sociologico per governare l'incertezza attraverso l'attività
didattica si propone :
-
un intenso investimento intellettuale nell'analisi delle attuali opportunità
e una valutazione realistica delle risorse disponibili; (esempio: analisi
delle variabili a livello demografico e del capitale proprio od altrui).
-
una critica immaginativa e positiva delle rappresentazioni sociali correnti in
merito a istituzioni, processi e relazioni; (esempio: analisi delle dimensioni
e caratteristiche della domanda e dell'offerta di lavoro)
- una
valorizzazione del concetto di interdipendenza.
- un
superamento dell'insidia enfatizzata dai media per cui tutto è facile da ottenere.
L'idea
base è: "se l'incertezza non può
essere sconfitta, può però essere ridotta, controllata e gestita".
L'obiettivo didattico corrispondente può essere quello di
comprendere ed acquisire la definizione dei termini
certezza/incertezza/rischio e assumere la capacità di utilizzarne gli
indicatori. Ne consegue che
quanto più una persona ha famigliarità con le differenti espressioni,
quantitative e qualitative, con cui si manifesta l'incertezza, tanto più è
disposta ad accettarla come una componente nei problemi della vita reale. Da
questa consapevolezza nasce lo stimolo a trovare soluzioni compatibili con i
dati a disposizione e, quindi, un'attitudine a relativizzare e a produrre
sensi di sicurezza e autostima.
c) l'ambito della didattica:
L'ambito
della didattica è stato prevalentemente occupato dalle tecnologie
multimediali. Sono stati presentati numerosi progetti e siti con obiettivi
molto ampi e una forte attenzione comune alle opportunità offerte dal
computer nell'insegnamento delle discipline economiche. Non abbiamo qui lo
spazio per analizzarli tutti: rinviamo alla pubblicazione degli Atti che è in
corso. Gli obiettivi riguardavano scambi di esperienze didattiche tra docenti
di vari paesi oppure progetti comuni, modalità diverse di usare World Wide
Web nell'insegnamento dell'economia, la gestione pratica nell'introduzione
dell'Euro e le relative simulazioni, l'integrazione tra economia politica ed
economia aziendale.
Le
opzioni offerte dalle nuove tecnologie consentono allo studente di ricercare
informazioni, di creare connessioni tra teorie ed esperienze, di simulare
situazioni ipotizzate per scoprire trends, di monitorare i propri percorsi e
attribuire significato ai contesti esplorati. Inoltre può comunicare con
altri studenti, anche di paesi lontani, e conoscere culture diverse dalla
propria.
Conclusione
Le
impostazioni teoriche, pedagogiche e didattiche, che hanno caratterizzato i
lavori della conferenza, sollecitano una formazione impostata
sull'uso di un metodo scientifico applicabile ad ogni ambito del sociale,
ma anche attenta all'esigenza di valorizzare ai fini dell'apprendimento le
emozioni e l'apprezzamento estetico. Ne deriva un sistema di valori
caratterizzati da atteggiamenti di
apertura verso gli altri, di cooperazione, di tolleranza e di senso della
realtà.
Dal
punto di vista organizzativo gli esiti della Conferenza dimostrano come tanto
i temi prescelti, quanto le modalità di svolgimento della manifestazione
hanno risposto alle attese dei partecipanti. Tutti hanno potuto presentare le
loro esperienze e i loro punti di vista sulle tematiche proposte. La
partecipazione alle sessioni plenarie, come agli workshop è stata numerosa,
coinvolgente e improntata a spirito di cooperazione.
sommario
* * *
3.
Inchiesta
sull’incertezza nelle rappresentazioni sociali dei giovani europei
di Doris Valente
Questo articolo è la sintesi di un articolo più
ampio che sarà disponibile negli Atti della 13ma Conferenza dell'AEEE, in
corso di pubblicazione.
1. Storia della ricerca
1.1 Obiettivi
L'idea di effettuare una ricerca sulle
rappresentazioni sociali dei giovani europei sulla tematica dell'incertezza e
del rischio è maturata all'interno del gruppo di lavoro dell'Aeee-Italia che
ha progettato la 13° Conferenza dell'AEEE (Association of European Economics
Education), tenutasi a Milano, presso l'Università Commerciale L. Bocconi
nell'agosto 2000.
Poiché lo scopo delle conferenze dell'AEEE è il
confronto su tematiche economiche e su pratiche
didattiche tra docenti europei, la rilevazione delle rappresentazioni sociali
sulla tematica della conferenza è sembrata un interessante spunto per la
riflessione didattica.
La scelta del tema "Incertezza e rischio nella
teoria e nell'attività economica" come asse portante della Conferenza ha
posto il problema di analizzare non solo gli aspetti teorici e le pratiche
degli attori economici, ma anche le implicazioni di tipo didattico.
L'obiettivo è stato quello di studiare i modelli di
"incertezza e rischio in economia" presenti nelle rappresentazioni
sociali di un campione di giovani studenti di alcuni paesi europei con una
preparazione di base in economia e/o in economia aziendale e di verificarne le
analogie e le differenze conseguenti a percorsi di studio simili nei
differenti contesti.
La ricerca è stata realizzata,
con il supporto della Commissione Europea nell'ambito di un'azione
Socrates-Misure complementari, in collaborazione, da A. Legardez - Y. Kérignard
(Cerpe-Iufm, Université de la Méditerranée d'Aix-Marseille - France),
P. Vergès (Lames, Centre National de la Recherche Scientifique - France) e D.
Valente (Aeee-Italia).
Nel febbraio 2000, l'équipe francese ha preparato il
questionario che è stato successivamente tradotto in inglese e in italiano.
Nei mesi di marzo-aprile 2000, gli studenti danesi,
francesi, italiani e svedesi hanno risposto al questionario in classe.
L'elaborazione dei questionari (maggio-agosto 2000)
ha richiesto la traduzione delle risposte dall'inglese e dall'italiano in
francese.
I primi risultati dell'inchiesta sono stati
presentati da A. Legardez e D. Valente nella 13ma Conferenza dell'AEEE
nell'agosto 2000 all'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.
Successivamente (gennaio-maggio 2001), per verificare
alcuni punti dell'inchiesta, in Francia e in Italia, hanno avuto luogo dei
colloqui esplicativi con piccoli gruppi di studenti che avevano risposto al
questionario nell'anno precedente
La ricerca è stata progettata con i seguenti
obiettivi
· rilevare e analizzare che cosa significa per degli
studenti europei "l'incertezza e il rischio in economia" .
· dedurne delle proposte per l'insegnamento delle
discipline economiche.
1.2 I fondamenti teorici della ricerca
L'inchiesta si è fondata sulla teoria delle
"rappresentazioni sociali" (P. Vergès) e sugli studi di didattica
delle discipline economiche e sull'analisi delle "preconoscenze"
all'apprendimento scolastico. (A. Legardez)
1.3 Metodologia e tappe della ricerca
1.3.1 Il questionario
Secondo l'impostazione degli esperti francesi, il
questionario è lo strumento chiave per rilevare in forma scritta, l'esistenza
di una rappresentazione sociale o la presenza di un "sistema di
rappresentazioni-conoscenze". Il questionario è formato da più domande,
nel nostro caso otto, più una scheda (anonima) di identificazione
dell'intervistato che ha lo scopo di verificare il contesto sociale di
provenienza del gruppo di studenti. Al questionario è premessa una pagina con
brevi note di presentazione della ricerca.
La prima domanda, di evocazione, ha lo scopo di
rilevare, attraverso l'associazione spontanea al concetto di "incertezza
in economia", i primi elementi della rappresentazione del tema. La
domanda aperta permette di selezionare le risposte
spontanee degli studenti senza alcun intervento sulla loro
immaginazione. Tutte le altre domande hanno lo scopo di verificare ciò che
viene associato all'incertezza e al rischio, per confermare o confutare le
rappresentazioni profonde emerse nella prima domanda.
E' infatti l'insieme di una variegata tipologia di
domande che permette di rilevare il sistema delle
rappresentazioni-conoscenze" per il tramite delle logiche cognitive
complementari.
Analiticamente l'inchiesta è stata effettuata
mediante le seguenti domande:
- la domanda "Quali concetti o espressioni vi
vengono in mente quando pensate all'incertezza in economia?" per rilevare
non solo le categorie economiche associate, ma anche l'ordine con il quale
sono state fatte le associazioni;
- le altre sette domande, destinate a confutare, a
confermare e/o a spiegare quanto affermato nella prima domanda. La domanda 2
richiede il collegamento tra i 12 termini scelti opportunamente; la domanda 3
propone l'associazione dei 18 item economici proposti con i campi del
"rischio", del "caso" e dell'"incertezza".; le
domande 4, 5, 6, 7 e 8 sono riferite agli attori del sistema economico e hanno
lo scopo di verificare quale immagine abbiano gli intervistati, per ogni
tipologia di attori, del peso dell'incertezza, della presenza di informazioni
e della loro influenza sul livello di incertezza, dell'importanza che esperienza e regole hanno sulla riduzione
dell'incertezza.
1.3.2 Popolazione intervistata
Nella definizione del campione si è tenuto conto
della diversità dei sistemi educativi presenti nel contesto dell'Unione
Europea. Sono stati scelti studenti di due paesi (Danimarca e Svezia) con un
sistema educativo basato su un modello di scuola superiore
"unitaria" con differenti programmi (modello scandinavo) e studenti
di due paesi del Sud (Francia e Italia) con un sistema educativo basato sulla
differenziazione degli indirizzi (modello mediterraneo).
Pur coscienti che il campione avrebbe potuto
comprendere altri due gruppi di studenti provenienti da paesi rappresentanti
degli altri due sistemi educativi presenti in Europa (modelli anglo-sassone e
germanico) non è stato possibile inserirli (per difficoltà legate ai costi e
al tempo).
Il campione degli intervistati era così composto:
- Francia : 129 studenti di 16-18 anni di licei (SES,
Economie-gestion, LP tertiaires);
- Italia: 200 studenti di 18-19 anni (IGEA)
- "Paesi Nordici" (Danimarca e Svezia): 93
studenti di 17-18 anni di licei (con opzioni in discipline economiche).
Nell'interpretazione dei risultati sono emerse alcune
difficoltà dovute alle tre versioni linguistiche del questionario
(italiano, francese, inglese) e alla loro percezione da parte dei
differenti gruppi di studenti (nazionalità, età, livelli e tipi di scuola
frequentati,…)
1.3.3 Colloqui esplicativi
Al fine di verificare e chiarire alcuni elementi
significativi rilevati mediante l'inchiesta effettuata con il questionario,
sono stati organizzati, nell'anno successivo (2001), alcuni colloqui con
studenti precedentemente intervistati.
I colloqui semistrutturati sono stati guidati secondo
uno schema predisposto dall'équipe di ricerca. Sono stati
diretti da un ricercatore con piccoli gruppi di studenti che avevano
risposto al questionario nel 2000. Gli incontri hanno avuto luogo in contesto
scolastico o in ambiente universitario, ma non sono stati condotti in
situazione didattica (in assenza di un insegnante).
Sono stati effettuati i seguenti colloqui:
- in Francia: con un gruppo di 10 studenti della
classe terminale ES
- in Italia: con 3 gruppi di studenti differenti
(complessivamente 11) - in ambito universitario o in scuole superiori).
2. Principali risultati
L'elaborazione dei questionari ha permesso di
evidenziare le analogie e le differenze dei diversi gruppi intervistati. Si è
innanzitutto cercato di analizzare se, nei diversi contesti presi in
considerazione, si potesse rinvenire un sistema di rappresentazioni-conoscenze
analogo. Alcune analogie sono state rilevate, anche se si è posto il problema
di confermare/esplicitare taluni punti emersi attraverso dei colloqui con
piccoli gruppi. Ciò è stato possibile in Francia e in Italia.
Facciamo qui ampiamente riferimento alle
comunicazioni presentate
nella 13ma Conferenza dell'AEEE (2000) e alle conclusioni della ricerca,
successive ai colloqui esplicativi, presentate da A. Legardez, nel Colloque
EERA di Lille (2001).
Dalla ricerca è emerso che gli studenti europei
intervistati rappresentano il funzionamento dell'economia secondo diverse
modalità.
Si possono individuare gli elementi di due modelli di
funzionamento dell'economia:
· un modello "Europa del Sud", più
interventista (Francia e Italia)
· un modello "Europa del Nord", più
liberale (Danimarca e Svezia)
Per esempio, gli
studenti del Sud pensano che, per diminuire l'incertezza in economia, siano
necessarie più regole, quelli del Nord pensano il contrario.
Il campo dell'incertezza
Il questionario ha permesso di capire che
l'incertezza in economia è direttamente collegata al concetto di
"crisi", alla quale si associano l'inflazione, il fallimento, la
disoccupazione. Essa concerne inoltre da
un lato la macroeconomia, cioè il funzionamento del sistema economico nel suo
complesso e, dall'altro lato, le paure dei soggetti intervistati sul loro
avvenire: lavoro, redditi, occupazione .
I colloqui permettono di precisare che l'incertezza:
· è la "vita" stessa di ciascuno
· concerne innanzitutto il campo del lavoro, vale a
dire la paura della disoccupazione
· non concerne il consumo perché il "consumo
è certo" ("si consuma anche senza reddito") ed "è
indotto dalla pubblicità che condiziona i consumatori".
Il campo del rischio
Il rischio è strettamente collegato alla gestione
dell'impresa e ai mercati finanziari (Borsa).
I colloqui permettono di precisare che i giovani
europei pensano:
· che gli imprenditori con più rischi siano i
"piccoli imprenditori"
· che i "grandi imprenditori" abbiano i
mezzi per assumere meno rischi, attraverso i mercati finanziari
L'incertezza e gli attori economici
Dai questionari emerge che gli attori economici
possono essere raggruppati in due categorie contrapposte:
- i "grandi" , "imprese
multinazionali", "banche", "assicurazioni",
"ipermercati".
- I "piccoli", "famiglie",
"salariati", "PMI (piccole e medie imprese)",
"piccolo commercio"
Il grado di incertezza che pesa sugli attori
economici è debole per i "grossi" e forte per i
"piccoli".
I colloqui permettono di aggiungere che:
· sui "grandi" pesa meno incertezza perché
dispongono di più mezzi e beneficiano di una migliore informazione; ma sono,
d'altra parte, più esposti ai rapidi cambiamenti dell'economia, che
paradossalmente aumenta il loro livello di incertezza.
I "piccoli" dispongono di pochi mezzi e
poche informazioni, ma questo è parzialmente controbilanciato dalla loro
esperienza locale e dalla loro parziale sconnessione dall'economia globale.
Le conseguenze dell'evoluzione del sistema economico
sull'incertezza
I colloqui hanno permesso di elaborare alcune
questioni, in particolare il rapporto tra l'incertezza e i cambiamenti del
sistema economico conseguente alla globalizzazione e all'aumento di
informazioni (Internet). In sintesi, dai colloqui emerge che la
mondializzazione (la globalizzazione) ha una doppia influenza:
- aumenta l'incertezza: infatti "quanto più ci
sono fattori che influenzano l'economia, tanto più c'è complessità e tanto
più cresce l'incertezza"
- ma diminuisce l'incertezza: sia a causa dello
sviluppo dell'informazione (Internet) , sia a causa della
"standardizzazione che appiattisce l'individuo".
Le conseguenze dell'evoluzione economica
sull'incertezza sono indeterminate anche perché Internet gioca un ruolo molto
ambivalente e l'innovazione frena l'incertezza. Ne consegue che
"l'economia corre più velocemente dell'informazione".
Possiamo dunque concludere con alcune osservazioni
emerse nei colloqui che ci permettono di evidenziare la vera natura
dell'incertezza per i giovani europei
"L'incertezza è una costante
nell'economia"
"L'incertezza è un elemento propulsore della
società: è positiva ….. ed è impossibile diminuirla perché è un
elemento strutturale."
"Il rischio dipende da nostre scelte,
l'incertezza dipende dagli altri"
3. Valutazioni finali e piste di lavoro
Gli studenti intervistati hanno risposto ponendosi
soprattutto da un punto di vista strettamente individuale, soprattutto nel
ruolo di consumatori (in particolare nel
Sud).
L'"incertezza in economia" non è una
questione socialmente "forte" per i giovani europei.
Dall'analisi dei risultati emerge che non esiste una
vera e propria rappresentazione sociale autonoma su "l'incertezza in
economia", con un nucleo fortemente strutturato e strutturante l'insieme
della rappresentazione (Vergès).
Si può individuare invece un "sistema di
rappresentazioni-conoscenze" (A. Legardez) che è il risultato di
un'elaborazione, avvenuta nel contesto scolastico, attivata da uno stimolo, cioè dal questionario che ha messo
in moto elementi di diversa natura, provenienti da:
· rappresentazioni sociali vere e proprie, sui
concetti di "crisi", di "mercato", di "lavoro",
di "redditi", di "consumo" ..
· residui di pre-conoscenze scolastiche di
precedenti esperienze, successivamente reinterpretati dagli intervistati
stessi.
E' emersa inoltre
una forte "contaminazione" di una rappresentazione sociale
sull'"avvenire" (il futuro) che i giovani attivano quando sono
stimolati sulle questioni dell'incertezza e del rischio (risultati dei
colloqui).
La maggior parte degli studenti intervistati ha
mostrato difficoltà a passare da una situazione centrata su di sé ad una
situazione che prende distanza dal sé per poter affrontare le questioni
economiche con distacco e razionalità.
Il grado di resistenza probabile ad un insegnamento
che assuma la dimensione dell'incertezza in economia potrebbe rivelarsi
differenziato:
· sarà forte per gli ambiti che coinvolgono
maggiormente l'individuo (per esempio il "consumo");
· sarà
debole per le questioni legate alla "crisi". Si può pensare che gli
studenti siano ricettivi di fronte a spiegazioni divergenti della crisi, cioè
in quegli ambiti nei quali si è evidenziata un'incertezza massima.
· gli allievi del Nord, tuttavia, potrebbero essere
più reticenti ad accettare delle teorie alternative (in particolare quelle più
interventiste).
Si osserva infine che, per tutti gli studenti
intervistati, solo il rischio, e non l'incertezza, rientra nell'ambito
dell'economia d'impresa.
sommario
4.
New Economy e old economics?
di Roberto Fini
1. Introduzione
Negli
ultimi anni la struttura economica è profondamente cambiata a causa di
quell’insieme di tecnologie che variamente vengono definite come rivoluzione informatica, net
o new economy.
Che il passaggio dalla old alla new economy sia davvero rivoluzionario
e possa segnare l’inizio di una nuova epoca economica, è probabilmente
presto per affermarlo con certezza.
Quello che di sicuro possiamo dire è che si tratta di un cambiamento
profondo, innescato, prodotto e sostenuto da quello che N. Negroponte ha
definito il passaggio “dagli atomi ai bit”.
La metafora di Negroponte sta a significare che la produzione della
ricchezza si sta progressivamente spostando dal tradizionale settore
industriale alla produzione di conoscenza.
Questo naturalmente non significa che la prospettiva sia un mondo privo
di prodotti industriali, ma che anche questi conterranno molta più conoscenza
che in passato.
Vedremo cosa ci attende per il futuro: se avranno ragione gli
apocalittici o gli integrati, se sorgeranno nuovi movimenti luddisti, se la
disoccupazione tecnologica sarà riassorbita, e così via.
Un elemento rispetto al quale occorre prestare attenzione è che in
questo quadro dinamico, nel quale fare previsioni ragionevolmente certe è
impossibile, la teoria economica stenta ad adeguarsi e a fornire strumenti
interpretativi convincenti.
Per usare un facile slogan: siamo davanti ad una new economy, ma spesso
letta con gli strumenti della old economics.
Che si tratti di un passaggio epocale, oppure di cambiamenti importanti
ma non strutturali del sistema economico, resta il fatto che si debbano usare
“ferri del mestiere”, strumenti interpretativi diversi rispetto a quelli
tradizionali.
Perché? Perché passare “dagli atomi ai bit” cambia comunque le
regole rispetto al passato; per riassumere in forma semplificata, può tornare
utile la tabella che segue:
|
Prevalenza di
atomi
|
Prevalenza di
bit
|
|
Legge dei rendimenti decrescenti
|
Legge dei rendimenti crescenti
|
|
Prevalenza del valore di scambio rispetto al valore
d’uso
|
Prevalenza del valore d’uso rispetto al valore di
scambio
|
|
Unicità del valore d’uso di un bene
|
Molteplicità del valore d’uso di un bene
|
|
Costi di transizione elevati
|
Costi di transizione bassi
|
2. Rendimenti
crescenti o decrescenti?
Nei
manuali di economia troviamo i concetti di utilità marginale decrescente,
nella teoria del consumatore, e di produttività marginale decrescente, nella
teoria dell’impresa.
Essi
derivano dall’osservazione che, ad esempio, l’utilità del secondo
bicchiere d’acqua è inferiore a quella del primo, il terzo poi ne ha ancora
meno, e così via fino al punto in cui l’utilità diventa negativa.
Si
tratta di un principio fondamentale per arrivare a costruire la curva di
domanda di un bene o di un servizio, così come la produttività marginale
decrescente serve a costruire la curva di offerta: il loro interagire
determina il prezzo di equilibrio.
Nell’economia di rete domina, invece, il principio dei rendimenti
crescenti; questo deriva dall’osservazione che, per esempio, la terza
postazione di internet accresce l’utilità delle prime due, la quarta delle
prime tre, ecc.: una rete con un milione di connessioni agisce in modo
qualitativamente diverso rispetto ad una che ne abbia solo mille.
In
altre parole, nella net economy si sviluppano circoli virtuosi autorinforzanti
per cui ogni nuova connessione produce un’utilità esponenzialmente
crescente per quelle preesistenti.
Un
principio analogo vale dal lato dell’offerta: più una rete viene usata, più
diventa attraente, più è veloce e più consente guadagni di produttività.
Il
che implica un cambiamento sostanziale nelle curve di domanda e di offerta e
quindi nella determinazione del prezzo: mentre nell’economia tradizionale,
man mano che il prezzo sale
l’offerta aumenta (perché vi sono maggiori margini di profitto) e la
domanda diminuisce (perché meno persone hanno i mezzi per comperare) e
l’equilibrio si trova ad un prezzo in cui le due si equivalgono, nella net
economy, poiché per effetto dei rendimenti crescenti più una risorsa viene
usata più viene richiesta (così come più si produce un servizio più
diventa facile – e conveniente – offrirlo), si innesta una forte tendenza
al calo dei prezzi, ma nonostante il prezzo scenda, l’offerta aumenta.
L’esempio
più evidente è dato dall’informazione finanziaria in rete: fino a poco
tempo fa fornire le quotazioni di borsa in tempo reale era costoso, pochi le
offrivano e pochi erano coloro che potevano acquistare il servizio.
In
internet spesso sono gratis e tutti le offrono: questo avviene perché vi sono
bassi costi fissi, costi marginali insignificanti e rapidità nella
distribuzione. Nel frattempo, proprio l’abbondante offerta gratuita crea
domanda aggiuntiva.
http://www.washingtonpost.com
3. Prevalenza del valore di scambio o del valore d’uso?
Anche il concetto di valore si evolve: nella teoria
economica tradizionale il valore di scambio predomina sul valore d’uso.
Nella
net economy la scarsità annulla il valore: chi vorrebbe un sistema chat
fantastico, se però lui è il solo ad averlo?
Nella
net economy il valore viene creato dall’abbondanza e dalla diffusione; e
poiché il valore cresce con l’abbondanza e l’abbondanza rende economica
l’offerta, si ha una forte tendenza alla gratuità: ecco perché regalare su
internet è una strategia logica (facilitando la diffusione si crea valore) e
perché si assiste ad una corsa ad affermare gli standard.
Il valore d’uso si moltiplica: mentre
nell’economia tradizionale ogni oggetto risponde allo scopo per cui è stato
creato, in quella di rete i valori d’uso spesso si moltiplicano.
Ad esempio, un indirizzo e mail offre
opportunità di archiviazione, di spedizione in blocchi ecc., mentre quanti
utilizzi vi vengono in mente se pensate ad un
martello, una sedia, ecc.?
4. Che cosa sono i costi di transazione?
In
un’impresa, per rifornirci di un bene possiamo rivolgerci al mercato,
comperando il bene (p.e. una confezione di graffette per fogli) nella quantità
necessaria, oppure rivolgerci al magazzino interno.
Se
ci rivolgiamo al mercato, dobbiamo affrontare i costi necessari per la ricerca
della disponibilità, per l’accertamento del prezzo più conveniente, per la
consegna del materiale, ecc.
Usando
le risorse interne, si evitano molti di questi costi, perché si è già
provveduto ad ottimizzare il flusso di informazioni necessario una volta per
tutte: il responsabile degli acquisti ha già accertato le migliori condizioni
per la fornitura, l’acquisto è avvenuto in partite cospicue e quindi con
minori costi di trasporto.
In
altre parole l’impresa ha due modi per ottenere le risorse di cui ha
bisogno:
procurarsele attraverso l’organizzazione interna
oppure reperirle attraverso il mercato.
Questo
equivale ad ipotizzare che esiste un trade-off fra queste due possibilità che
verrà risolto sulla base della convenienza in termini di maggiore o minore
costo.
I costi di
transazione emergono quando una certa quantità di risorse viene assorbita
da diversi aspetti della transazione, come la redazione del contratto, il
controllo sull’adempimento degli obblighi contrattuali, ecc.
Il
primo ad occuparsi dei costi di transazione in modo organico fu R.
Coase nel 1937; il suo contributo appare particolarmente rilevante in
quanto egli legò la nascita dell’impresa in quanto organizzazione complessa
al tentativo di ridurre i costi di transazione incorporando all’interno
dell’impresa stessa funzioni altrimenti affidate al mercato: poiché
effettuare scambi sul mercato comporta dei costi, gli attori cercheranno di
sostituire al mercato una struttura gerarchica – appunto l’impresa – che
riduce la necessità di compiere transazioni e quindi i costi ad esse
connessi.
Un’impresa tenderà ad espandersi esattamente fino
al punto in cui “i costi indotti dall’organizzazione di una transazione
addizionale al suo interno eguagliano quelli della stessa transazione eseguita
attraverso uno scambio sul mercato aperto”.
Per
attività semplici rivolgersi al mercato aperto è una soluzione efficiente e
razionale perché i costi di transazione sono trascurabili; per attività su
vasta scala, che richiedono coordinamento, massicci investimenti di capitale,
complessi sistemi di distribuzione, ricorrere alla forma organizzativa
dell’impresa è l’unica soluzione valida dal punto di vista economico.
Benché
sia valida come soluzione, essa è molto lontana dall’essere perfetta: lo
svolgimento di una funzione all’interno dell’impresa comporta un costo
dovuto all’esistenza di un apparato preposto alla comunicazione e al
coordinamento, noto nel suo complesso come “burocrazia”.
La
burocrazia tende a crescere con le dimensioni e la complessità
dell’impresa, e a volte provoca costi che si avvicinano o superano i costi
di transazione a cui darebbe luogo l’alternativa di mercato.
La tecnologia (non solo quella informatica) tende a
ridurre i costi di transazione e rende possibile e conveniente la creazione di
imprese di maggiori dimensioni. Possiamo definire questa dinamica come legge
di espansione dell’impresa: essa è stata tipica dell’evoluzione della
forma impresa fino a non molto tempo fa.
Fino
ad oggi il ruolo svolto dalle tecnologie digitali è stato coerente con questa
analisi: computer, reti, grandi capacità di memorizzazione dei dati, ecc.
hanno reso possibile la comparsa di imprese più grandi e più complicate, che
internalizzano un numero sempre maggiore di funzioni di mercato.
Questa
tendenza si sta invertendo rapidamente: la tecnologia, dopo essere stata la
causa di questa tendenza all’aumento delle dimensioni e delle funzioni
dell’impresa, ora ne è divenuto il peggiore incubo.
Infatti,
oltre ai costi di gestione dell’impresa la tecnologia digitale riduce anche
quelli del mercato: non è soltanto l’impresa a diventare più efficiente,
ma anche il mercato si evolve nella stessa direzione.
Le
tecnologie digitali operano in modo da creare un mercato nel quale i costi di
transazione si riducono in modo sempre più accelerato.
Per
tornare all’esempio delle graffette, oggi comincia a non essere più
conveniente disporne di una quantità elevata attraverso il magazzino interno,
ma fare un ordine via internet per approviggionarsene nella quantità
necessaria.
Che
anche il mercato potesse diventare più efficiente grazie alla riduzione dei
costi di transazione è un’ipotesi che Coase non prese in considerazione,
ma, se si verifica, essa ha un risultato facilmente prevedibile, proprio in
funzione della “natura” delle imprese: se le imprese accrescono le proprie
dimensioni fino al punto in cui la transazione addizionale non costa meno di
quanto costerebbe se venisse svolta all’esterno, che cosa accade quando
diventa più economico operare tramite il mercato?
La
naturale conseguenza è che l’impresa riduce le proprie dimensioni. Se Coase
ha visto giusto a proposito della relazione fra imprese e costi di
transazione, allora è possibile ipotizzare una dinamica nuova che possiamo
definire legge di contrazione
dell’impresa.
Le legge di contrazione dell’impresa è
naturalmente di natura tendenziale e le sue conclusioni sono paradossali;
resta il fatto che un’impresa veramente priva di attriti non avrebbe
necessità di imprese permanenti.
Questo
è impossibile, ma resta il fatto che il concetto di impresa come entità
fisica definita dalla permanenza del personale e delle risorse fisse, sta
perdendo terreno rispetto a quella che viene definita “impresa virtuale”,
nella quale la struttura è molto più leggera, i dipendenti possono lavorare
a tempo parziale o su appalto, le risorse possono essere di proprietà comune
fra diverse imprese, la separazione fra la sfera interna e quella esterna
all’impresa diventa sempre più vaga.
http://www.washingtonpost.com
La
struttura del complesso delle imprese tende sempre più a mutuare il concetto
giapponese di keiretsu: in Giappone
sono così definiti quei raggruppamenti di società finanziarie, commerciali
ed industriali caratterizzati da relazioni flessibili ed informali tra i
membri.
I
vantaggi che ciascuna impresa partecipante alla keiretsu
ricava sono costituite dalle economie di scala (ottenute sviluppando le
conoscenze o sfruttando le strutture di altre aziende collegate) e il
reciproco sostegno finanziario.
5.
Apriamo
un forum di discussione: Dove vanno le discipline
economiche aziendali e giuridiche?
Intervento di Elide Sorrenti
Durante
l'arco di tre anni i rappresentanti delle maggiori associazioni disciplinari
italiane si sono riuniti periodicamente
a Bologna con lo scopo di confrontare i rispettivi punti di vista
relativamente al ruolo delle proprie discipline in rapporto alla riforma del
sistema scolastico italiano in fase di elaborazione e, in parte, di
attuazione.
Il
quadro dell'analisi era costituito dal cosiddetto documento dei saggi, dalla
proposta di introduzione dei cicli e dalle opportunità operative offerte
dall'autonomia.
Si
trattava di esplorare la base ed il progetto culturale portante del curricolo
nella scuola riformata. I lavori hanno toccato diversi ambiti, tra i quali la
trasversalità dei linguaggi e delle operazioni mentali, e la ricerca di un
vocabolario da condividere circa i punti emergenti dalle proposte ministeriali
e dal documento dei saggi, quali ad esempio "i saperi minimi o
essenziali", "i nuclei portanti delle discipline", "le
competenze". In merito alle tre posizioni, che ponevano rispettivamente
l'accento sulla centralità dell'alunno, su quella dei problemi sociali e
sulla centralità del sapere è stata scelta quest'ultima giustificata
dall'ipotesi,che prevedeva un curricolo basato sulle competenze.
Infatti,
partendo dalla centralità del
sapere si possono identificare le mediazioni psicologiche, pedagogiche e
didattiche atte a realizzare le finalità formative rivolte alla centralità
dello studente
Un
secondo problema affrontato: quale/quali saperi per il curricolo delle
competenze?
Ne
è emersa la necessità dell'analisi disciplinare per individuarne lo
specifico, ossia i problemi affrontati,
il contesto, i paradigmi, i contenuti, i metodi, l'evoluzione storica. Da
questa analisi è possibile
passare alla/alle materie di insegnamento, e scegliere i concetti e il saper
fare, che consentono di far acquisire le competenze richieste dal profilo
culturale o professionale della scuola interessata. Su questa base è quindi
possibile costruire un curricolo. Il Forum ha adottato l'ipotesi del
curriculum verticale o a spirale, in cui
si passa via via dal livello pre-disciplinare a schemi in cui
gradualmente le discipline assumono il loro carattere autonomo.
Tenendo
conto del fatto che ogni sapere presenta un carattere epistemologico,
costituito dalle rete dei concetti strutturati,
uno formativo inerente la persona e uno orientativo riguardante i
talenti e la professione, le finalità delle discipline giuridiche ed
economiche sono diverse a seconda che vengano riferite alla scuola di base
intesa in senso lato, all'educazione giuridica e economica, quale quella di un
biennio, e quella professionalizzante a livello superiore.
a)
nella scuola di base le competenze da acquisire sono essenzialmente di tipo
trasversale, le conoscenze terminologiche derivate dal senso comune sono usate
anche dal diritto e dall'economia. Pensiamo per esempio al sentimento del
"giusto" ai concetti
di"legge" o "diritto", all'espressione "fare
economia" o "risparmiare". Consideriamo le conoscenze e le
capacità procedurali , quali saper correlare fenomeni per dare spiegazioni,
in certi casi anche con il ricorso ai numeri e ai calcoli per misurare le
dimensioni, rapportarne le grandezze e per risolvere problemi. Come pure
la percezione del tempo a partire dal presente e dallo spazio
circostante favorisce l'apprendimento di
categorie, trasversali anche queste, che fanno acquisire il senso della
continuità, del cambiamento e della trasformazione nelle relazioni personali
e in quelle con l'ambiente. Nella scuola di base competenze e capacità
relative a questi ambiti disciplinari si esplicheranno con l'apporto e a
supporto della lingua italiana, della matematica, della storia,
dell'educazione tecnica, della geografia.
b)
l'educazione giuridica ed economica ha la finalità di mettere il cittadino in
grado di comprendere il contesto socio-economico, che ha di fronte, e in cui
svolge e svolgerà determinati ruoli a seconda delle sue scelte. Le competenze
che si richiedono a questo livello riguardano, per un verso, la conoscenza di
sé, la scoperta della propria identità, anche come soggetto portatore di
diritti e quindi capace di progetti, per l'altro verso, la conoscenza della
realtà sociale in cui inserirsi e su cui intervenire.In altri termini è
necessario sapersi orientare. A questo livello i nuclei fondanti portano a
concetti chiave, quali rapporto giuridico o scambio, e al loro sviluppo, che
richiedono una terminologia correttamente formalizzata.
c)
Area di professionalità: il diritto, l'economia, il diritto tributario, la
scienza delle finanze, l'economia aziendale sono materie derivanti dalle
specializzazioni disciplinari. Il loro impiego può essere diversamente
articolato e dosato a seconda della professionalità perseguita. Le competenze
si basano sulle conoscenze previste dal profilo professionale,
sulle relative capacità procedurali e sulle quelle relazionali.
Si
è inoltre concordato di suggerire l'utilizzo di moduli disciplinare e
interdisciplinari , là dove possibile, come pure l'adozione di
metodologie didattiche attive,
che favoriscano l'autoapprendimento e l'autovalutazione.
Intervento di Sergio Zangirolami
Penso che la posizione dell'insegnamento
dell'Economia (economia politica, politica economica, scienza delle finanze)
vada attentamente considerata, per vedere elementi favorevoli e sfavorevoli
nei programmi introdotti in questi ultimi anni.
Mi riferisco, particolarmente, ai programmi IGEA
(Indirizzo Giuridico Economico Aziendale, dove quell'aziendale può essere
paritetico con giuridico ed economico, ma potrebbe anche essere qualificativo
di economico e da leggere quindi economico aziendale) e ERICA (Educazione alla
Relazione Interculturale nella Comunicazione Aziendale).
Come è ben noto, l'IGEA è diventato ordinamento
negli Istituti commerciali e quindi sarà opportuno confrontarlo con i vecchi
programmi di questi Istituti.
La prima grande innovazione è consistita
nell'inserire fra le materie del biennio un insegnamento di diritto ed
economia, con due ore settimanali. L'indicazione è importante, perché
significa riconoscere all'insegnamento di base di elementi di diritto e di
economia una risposta "alle esigenze di formazione del cittadino in
quanto tale". E questo carattere, indipendentemente dal proseguimento
degli studi nel successivo triennio, dato che "non ha funzione
strettamente propedeutica allo studio triennale di indirizzo".
Gli obiettivi, però, lasciano perplessi per la loro
complessità. Si dice, infatti, che alla fine del biennio, per quanto riguarda
l'economia (anche se viene precisato che il corso è caratterizzato "non
come giustapposizione di due discipline, ma come integrazione di esse"),
lo/a studente/essa deve saper:
- riconoscere, spiegare e utilizzare il linguaggio
economico;
- individuare le essenziali categorie concettuali
dell'economia;
- conoscere i settori di attività prevalenti sul
territorio e i fondamentali operatori economici del sistema economico;
- descrivere il ruolo dello Stato nell'economia;
- consultare in modo autonomo fonti e testi
economici;
- confrontare modelli economici con soluzioni
reali;
- distinguere tra le potenzialità e i limiti degli
schemi interpretativi del sistema economico.
Uno/a studente/essa che sapesse, a quindici-sedici
anni, fare con piena consapevolezza tutto ciò che abbiamo appena riportato,
sarebbe senz'altro geniale.
Passando al triennio e confrontando i programmi Igea
con quelli preesistenti, si notano intanto mutamenti negli aspetti che vengono
particolarmente messi in evidenza.
Mentre i programmi precedenti avvertivano che
"l'insegnamento dell'economia politica e delle altre discipline connesse
va impartito cercando di contemperare la conoscenza teorica dei vari fenomeni
con quella empirico-professionale, la quale, pur potendo apparire come scopo
ultimo, trova nella prima la sua necessaria base e la sua fonte di
interesse", facendo quindi esplicito riferimento anche al carattere
professionalizzante della disciplina; le finalità Igea accentuano la
conoscenza dei principi e delle teorie nel loro contesto storico fino a
suggerire, nelle indicazioni metodologiche di:
- utilizzare un testo di storia del pensiero
economico per avvicinare i giovani agli scritti originali degli autori;
- sottolineare l'importanza delle diverse teorie, che
rappresentano modelli interpretativi alternativi;
- evidenziare che ogni modello interpretativo non è
mai rigorosamente neutrale, ma risente del bagaglio ideologico soggettivo di
ciascun economista.
Questo perché è importante "sviluppare negli
studenti la capacità di interpretare le problematiche economiche sia in senso
storico evolutivo sia in senso sistemico al fine di rendere i giovani capaci
di operare scelte motivate". Scelte motivate come cittadini, si può
immaginare, e non tanto come diretti operatori economici. Orientamento
positivo, dunque.
Confrontando, ora, gli spazi orari che, in attesa di
una più profonda riforma che disegni cattedre pluridisciplinari, sono
operanti nelle nostre scuole, appare questo quadro:
ITC
indirizzo amministrativo (dpr 30/9/1961 n. 1222) triennio 2 3 3 (diritto 4 3
3) ( Ragioneria 3 4 4 Tecnica comm 3 3 2 ) Igea (Indirizzo giuridico economico
aziendale)biennio diritto ed economia 2 2
( Economia aziendale 2 2 )triennio 3 2 3 (diritto 3 3 3) (Economia
aziendale e labor. 7 10 9)
Balza agli occhi che la distribuzione delle ore
privilegia fortemente Economia aziendale (che ha assorbito le ore di
laboratorio), mentre diminuisce di un'ora l'Economia della quarta. E' noto a
tutti come passare da 3 a 2 ore settimanali cambi radicalmente la presenza
della materia.
Ecco che il dubbio se quel economico aziendale
dovesse essere letto insieme acquista peso. Sia ben chiaro, nessuna contesa
fra insegnamenti, ma un chiarimento se l'asse portante dell'insegnamento
dell'economia sia rappresentato dall'Economia (economia politica, politica
economica, scienza delle finanze) o dalla Economia aziendale.
Il dubbio si fa certezza quando si consideri Erica,
che ha voluto potenziare l'insegnamento delle lingue - e in questo è
meritorio- ma ha allontanato definitivamente l'Economia. Vediamo i programmi,
confrontandoli con quelli dei Periti aziendali e corrispondenti in lingue
estere da cui Erica deriva:
IT
Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (dm 8/8/1966)
triennio econ e diritto 5 4 4 (Tecnica
3 5 5 5 )
Erica (Settore economico aziendale - Indirizzo linguistico aziendale)biennio
Educazione giuridico economica 2 2
triennio Diritto ed Economia per l'azienda 5 6 6
Come si vede, a parte le 2 ore nel biennio, nel
triennio rimane soltanto Economia per l'azienda.
Ora, proprio nella finalità più ampia di formare
cittadini, oltre che bravi Ragionieri, considerare la complessità delle
vicende economiche solo nell'ottica aziendale, può venire incontro alla
deriva del pendolo di questo ultimo decennio, ma è, a mio parere, fortemente
limitante.
Mi auguro che molti colleghi intervengano in questo
dibattito, per sentire se questi dubbi sono il solo risultato delle gelosie di
un vecchio (di servizio) insegnante o sono condivisi anche da altri.
sommario
6.
Nuovo sito AEEEItalia
di
Giuseppe Tramontana
E’ in fase di allestimento il nuovo sito internet
dell’Associazione. La registrazione di un dominio ci consentirà di avere un
nuovo indirizzo web personalizzato ed una gestione autonoma delle pagine. Il
sito sarà on line nel mese di ottobre (salvo imprevisti di natura
amministrativa col Provider) all’indirizzo https://www.aeeeitalia.it
.
Il nuovo sito avrà una nuova veste grafica rispetto
al precedente, novità nei contenuti e nuove sezioni al suo interno.
Sotto il profilo della grafica risulta infatti
notevolmente accentuata la personalizzazione attraverso l’identificazione di
tutte le pagine con lo sfondo raffigurante il logo dell’AEEE. Anche i colori
riprendono costantemente i motivi del logo. Le pagine inoltre avranno una
struttura con frames: saranno cioè divise in due parti, a sinistra un menu
con pulsanti, tutti personalizzati con il logo dell’Associazione, che
suddividono il sito stesso in più sezioni e, a destra le pagine riguardanti
le singole sezioni.
La struttura delle singole sezioni ed i rispettivi
contenuti sono stati arricchiti ed innovati rispetto alla precedente versione:
la razionalizzazione consentirà pertanto una più agevole consultazione e
gestione di tutti i documenti presenti nelle pagine.
Nella Home
page sono riportati gli scopi e le attività della Associazione in forma
molto schematica per facilitare immediatamente la lettura e la comprensione
anche per i non addetti ai lavori.
La prima sezione Attività associative riporta invece nel dettaglio le più salienti
iniziative svolte fino ad oggi dall’AEEE; ci
sono anche i nominativi e gli indirizzi (e mail) dei responsabili.
Nella seconda sezione News si riportano le novità riguardanti attività didattiche,
aggiornamenti ed altre attività proposte dall’AEEE.
La sezione dedicata alle Newsletter contiene le riviste pubblicate dall’AEEE italiana
perio-dicamente; in seguito potrebbe anche contenere le newsletter dell’AEEE
europea.
La struttura di questa sezione consente di consultare
già on line i documenti e fornisce in più la possibilità di effettuare il
download sul proprio computer per una consultazione off line. Tutti i
documenti presenti sul sito sono muniti di questa duplice caratteristica: la
consultazione on line inoltre viene effettuata mediante l’apertura di
finestre indipendenti che non distolgono il lettore dalla consultazione del
sito.
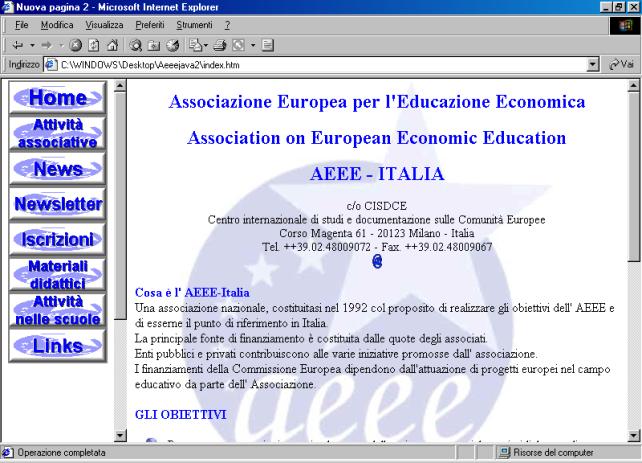
Altra novità è la sezione Iscrizioni che contiene un modulo dinamico di adesione all’AEEE:
ciò permette la gestione delle nuove associazioni e dei rinnovi completamente
on line.
La sezione Materiali
didattici contiene documenti utili ai docenti di economia. Anche questi
documenti possono essere consultati o scaricati sul proprio computer.
La nuova sezione Attività nelle scuole conterrà le varie attività svolte dalle
scuole, delle quali siamo a conoscenza. La finalità è di renderle note e
metterle a disposizione di chiunque sia interessato. Qui è possibile la
segnalazione da parte di chiunque di tutte le iniziative interessanti di cui
si è a conoscenza.
L’ultima sezione riguarda i Links nella quale si fa una raccolta, divisa per argomenti, delle più
importanti risorse esistenti sulla rete internet utili per ricerche o
aggiornamenti. La raccolta dovrebbe essere arricchita ed aggiornata anche
dalle segnalazioni fornite dai lettori.
La sezione è suddivisa in tante sotto sezioni
visibili allorquando si pigia il pulsante Links.
Riguardano i Motori di ricerca, Media (quotidiani e
riviste), Istituzioni italiane, Diritto, Unione Europea, Economia e
l’ultima, Varie nella quale si raccolgono indirizzi utili alla ricerca ed
alla didattica ed altro.
Tutti i links di questa sezione e gli altri presenti
nelle altre pagine del sito sono corredati da recensione e possono essere
visitati mediante l’apertura automatica di una nuova finestra; questa
struttura permette ai “naviganti” di non essere distolti dalle pagine
principali del sito e quindi evitare le fastidiose operazioni di ‘avanti’
e ‘indietro’ del browser.
Il sito oltre che essere graficamente gradevole sotto
il profilo estetico (ci auguriamo lo sia) deve però essere continuamente
aggiornato ed arricchito di contenuti, iniziative e nuove idee; pertanto vi
invitiamo già da subito a scrivere le vostre impressioni, suggerimenti, e
tutto ciò che di interessante abbiate all’indirizzo e mail contenuto nella
Home (ed anche in altre sezioni).
7.
XIV Conferenza
dell'Associazione
Europea di Educazione Economica (AEEE)
di Doris Valente
Acquisgrana,
Germania, fine Agosto 2002
Nel
2002 , alla fine del mese di Agosto, ad Aachen (in Germania) si terrà la
prossima Conferenza dell'AEEE.
Il gruppo tedesco dell'Aeee ha preparato la domanda
alla Commissione UE per un progetto "Socrates-Misure Complementari"
che vivrà il suo momento culminante nella 14ma Conferenza .
Il titolo del progetto e della conferenza è "Cross-cultural
Behaviour in European Business Education and Training".
Il progetto si rivolge a formatori di livello
universitario e di centri di formazione, a insegnanti di scuole secondarie e
professionali, e , indirettamente ai loro allievi. Prende spunto dalla
seguente riflessione: poiché si verifica spesso che atti economici che
interessano il livello interculturale diano origine a decisioni scorrette e
costose, è importante che la formazione generale e professionale sviluppi
condizioni atte favorire il buon funzionamento delle relazioni economiche e di
cooperazione oltre frontiera.
Il progetto vuole creare una rete di competenze
europee nel campo della formazione delle discipline economiche e aziendali per
migliorare i comportamenti interculturali spesso all'origine di incomprensione
e problemi. La rete chiamata "Cross-cultural Behaviour in Business
Education and Training" (c-cbb) persegue i seguenti scopi:
· la crescita della
qualità della formazione professionale in Europa mediante la riflessione e la
diffusione di diversi modelli di formazione
· la sensibilizzazione del mondo della scuola e
degli specialisti nel campo della formazione ai temi proposti in una
dimensione europea, servendosi di Internet e degli strumenti di comunicazione
interattiva e tenendo conto dello studio delle lingue nella formazione
continua
· l'apprendimento di competenze in campo economico e
la promozione di pari opportunità sul mercato del lavoro europeo, con
l'obiettivo di eliminare i sentimenti xenofobi e razzisti.
La Conferenza vuole favorire lo scambio di esperienze
acquisite nel campo dei programmi della formazione avvalendosi del sito"c-cbb"
(homepage http://www.c-cbb.de)..
"C-cbb" pubblica i modelli di formazione
praticati con successo nel quadro della formazione professionale europea e
vuole offrire corsi per formatori on-line su scala europea, diffondendo
informazioni e documenti destinati alla conferenza, mettendo a punto un
curriculum ad hoc
La professionalità potrà crescere grazie alla
pubblicazione di un modello di formazione "aperto" che potrà essere
realizzato a medio termine nei diversi sistemi nazionali di formazione
professionale.
sommario
8.
Recensioni di
Sergio Zangirolami
Paul Krugman
Economisti
per caso (1998)
Garzanti
2000
pagg.
180 Lit. 29.000 (14.98 euro)
Krugman insegna al MIT ed è un columnist del “New
York Times”, quindi un accademico che volentieri prende posizione sulle
questioni economiche più rilevanti, rivolgendosi al pubblico dei lettori. In
questo libro vengono raccolti articoli apparsi tra il 1995 e il 1997. Il tono
è dunque discorsivo, ma radicato sulla conoscenza certa dei principi
dell’economia. La tesi che sottostà a tutti gli articoli è che spesso
vengano sostenute delle interpretazioni dei fatti economici e delle
indicazioni per gli interventi (da fare o da non fare, visto il clima che
tende a sminuire la politica economica) del tutto errate. E quanto più le
dimostrazioni sembrano logiche e facilmente comprensibili, tanto più Krugman
ci mette in guardia.
Per esempio, la teoria dell’offerta, come è noto,
afferma che i tagli delle imposte hanno un effetto così positivo
sull’economia che non occorre compensarli con tagli di spese. Ma attenzione,
ci dice Krugman, questa teoria non ha prove concrete in suo favore e, quando
Clinton nel 1993 ha fatto passare un aumento delle imposte per le famiglie di
alto reddito, mentre autorevoli mezzi di informazione (come Forbes e il Wall
Street Journal) prevedevano recessione e aumento del deficit federale, negli
anni seguenti “l’economia ha creato milioni di nuovi posti di lavoro,
praticamente ogni giorno la borsa ha segnato nuovi record, e il deficit si sta
dileguando”. Allora, una teoria che prevede determinate conseguenze, mentre
se ne verificano di opposte, non è certo molto affidabile, anche se ha avuto
il sostegno entusiasta dei ricchi.
Oppure, affrontando il tema della globalizzazione,
Krugman raccoglie le critiche di chi osserva che in questo sistema vi sono
milioni di lavoratori nei paesi sottosviluppati che vengono sfruttati con
salari bassissimi, al di sotto di quanto consideriamo il minimo vitale, ma
sostiene che “un lavoro brutto e malpagato è meglio di nessun lavoro e, per
quanto i salari e le condizioni di lavoro nelle nuove industrie esportatrici
del Terzo Mondo siano spaventosi, essi costituiscono un sensibile
miglioramento rispetto alla precedente, meno appariscente, povertà rurale”
Queste affermazioni, contro quello che egli respinge come “oltranzismo
morale”, possono apparire ciniche, ma ci obbligano a riflettere su un
fenomeno che non permette ricette troppo semplificate.
E’ proprio in questo stimolo alla riflessione che
risiede il maggior pregio di questo libro.
Enrico
Cisnetto
Il
gioco dell’OPA
Sperling
& Kupfer 2000
pagg.
340 Lit. 34.000 (17,56 euro)
Si sono appena concluse, nell’estate del 2001, le
due più importanti scalate nell’economia italiana: la Telecom, con la
cordata Pirelli-Benetton e la Montedison, con la Fiat e la francese EDF. Sono
tornati in mani storiche (Fiat e Pirelli, oggi Tronchetti Provera) due settori
fondamentali per la new economy: le telecomunicazioni e il controllo
dell’energia.
Il libro di Cisnetto, giornalista economico, è
scritto un anno prima e descrive dettagliatamente le manovre intorno alla
Telecom, privatizzata nel 1997 e oggetto nel 1999 di una clamorosa scalata da
parte di Colaninno per mezzo della Olivetti. Fanno da contorno, determinante,
vicende bancarie (il fallito blitz da parte di Unicredito e IMI-Sanpaolo per
la conquista di Comit e Banca di Roma) e assicurative (l’assalto delle
Assicurazioni Generali all’INA) ed è ancora presente con Enrico Cuccia il
potere, da cui non era possibile prescindere, di Mediobanca.
Morto Cuccia, le cose sono rapidamente cambiate e la mediazione di
Mediobanca è diventata sempre meno richiesta e indispensabile.
Il libro si legge come un giallo, ricco di colpi di
scena, raccontati in stile giornalistico. La documentazione è, però, di
prima mano e vengono chiaramente distinti i fatti dalle congetture. Succede,
talvolta, di perdersi tra i numerosi nomi e sigle, ma con un poco di
attenzione si riesce a riprendere il filo, tenendo ogni volta presenti i
protagonisti principali, gli obiettivi e le mosse per raggiungerli.
Come si vede dal confronto fra le vicende narrate e
quelle succedute poco tempo dopo, la situazione è in veloce movimento, anche
perché l’entrata in campo di potenze finanziarie straniere (EDF e
Montedison insegna) allarga il numero dei protagonisti e rende indispensabili
strategie fondate su alleanze transnazionali. Un’ultima impressione,
scontata ormai, riguarda il prevalere della finanza sull’attività
produttiva. Non si tratta di una novità, ma rimane una costante anche nel
passaggio dalla old alla new economy.
John K. Galbraith
Facce
note (1999)
Rizzoli
(2000)
pagg.
222, Lit. 28.000 (14.46 euro)
Molte persone, raggiunta una certa età e avendo
avuto una vita prestigiosa, tracciano una loro autobiografia. In questo breve
libro, il grande economista John K. Galbraith scrive “Quasi
un’autobiografia”, perché i ricordi sono organizzati sui personaggi di
primo piano che l’autore ha conosciuto e frequentato. Sappiamo che Galbraith,
oltre che economista accademico e grande divulgatore (ricordiamo tutti “La
società opulenta”, “Il grande crollo” e innumerevoli altri libri in cui
l’economia veniva raccontata con originalità di pensiero e ricchezza di
esemplificazioni), esprimendo l’impegno sociale del liberal (che negli Stati
Uniti indica il pensatore progressista, impegnato nelle battaglie per i
diritti civili) ha collaborato con i Presidenti e gli uomini politici che più
hanno rappresentato nel Nordamerica e nel mondo il progresso, come poteva
venire interpretato da un paese potente a economia capitalistica (e, quindi,
con le inevitabili e gravi ombre ombre, come ad esempio la guerra del
Vietnam).
Ecco che allora, in questa breve galleria di
personaggi, Galbraith si colloca a fianco (e, conoscendo la sua storia, non si
tratta in nessun caso di millantato credito) di Franklin D. Roosevelt, al cui
New Deal ha collaborato negli anni trenta per far uscire gli Stati Uniti dalla
più grave depressione della loro storia, di John F. Kennedy e del suo
successore Lyndon B. Johnson. E, insieme, delle persone che hanno avuto un
ruolo determinante nella politica di questi personaggi, come Eleanor Roosevelt
e Jacqueline Kennedy. Al di fuori degli Stati Uniti, solo due facce note:
Javaharlal Nehru, primo ministro indiano, conosciuto prima come consulente
economico e poi come ambasciatore degli Stati Uniti a Nuova Delhi; e
inaspettatamente, Albert Speer, responsabile dell’economia bellica nella
Germania di Hitler durante la seconda guerra mondiale, che Galbraith aveva più
volte ufficialmente interrogato alla fine della guerra per conto degli Alleati
(Albert Speer ebbe salva la vita, ma fu condannato a vent’anni di
detenzione).
Si tratta di un libro che si scorre molto facilmente,
anche se presuppone che si conoscano a grandi linee gli avvenimenti che vi
vengono descritti.
Jeremy Rifkin
L’era
dell’accesso
Mondadori
2000
pagg.
406 Lit. 35.000 (18.08 euro)
Rifkin è presidente della Foundation on Economic
Trends di Washington e insegna alla Wharton School of Finance and Commerce,
dove tiene corsi sul rapporto fra l’evoluzione della scienza e della
tecnologia e lo sviluppo economico, l’ambiente e la cultura. Proprio
riflettendo sull’impatto delle nuove tecnologie, egli non si limita a
descrivere la globalizzazione in termine di diffusione degli scambi e delle
conoscenze, ma ne deriva delle trasformazioni strutturali che dovrebbero
conferire ai prossimi decenni un carattere di vera rivoluzione. L’idea
principale del suo libro (lo conoscevamo per altri lavori tradotti in
italiano, come Entropia del 1980 e La fine
del lavoro del 1995) è che per la prima volta nella nostra storia la
proprietà dei beni materiali viene sostituita dall’accesso a ogni tipo di
bene o servizio, contro pagamento di canoni di leasing, tariffe, abbonamenti.
Da un lato “Lo scambio di proprietà fra compratori e venditori -
l’aspetto più importante del moderno sistema di mercato - cede il passo a
un accesso temporaneo che viene negoziato fra client
e server operanti in una relazione
di rete. Il mercato sopravvive, ma è destinato a giocare un ruolo sempre meno
rilevante nelle attività umane.”, dall’altro la nuova forza dominante e
più ricercata è il capitale intellettuale, che crea idee, concetti, immagini
e che rimane in possesso del fornitore e da lui noleggiato o messo a
disposizione per un uso limitato. Ciò non significa che verrà meno la
produzione di beni materiali, ma non è casuale che nei paesi più sviluppati
gli uomini più ricchi non sono i produttori ma i gestori delle reti
televisive, delle grandi società di pubblicità, con cui ormai si arriva a
possedere anche il potere politico. Rimane quella larga parte del mondo che
dipende dalla disponibilità di beni materiali per la sua sopravvivenza fisica
“Mentre un quinto della popolazione mondiale sta migrando verso il
ciberspazio e le relazioni di accesso, il resto dell’umanità è ancora
intrappolato in un mondo in cui scarseggiano i beni materiali. Per i poveri,
la vita rimane una lotta quotidiana per la sopravvivenza, e disporre di
proprietà costituisce una preoccupazione immediata (per alcuni destinata a
rimanere un obiettivo distante). Il loro mondo è lontanissimo dai cavi a
fibre ottiche, dalle connessioni satellitari, dai telefoni cellulari, dagli
schermi dei computer e dalle reti del ciberspazio.” Convinto della strada
che abbiamo di fronte, Rifkin non pensa che necessariamente debba portare a
colmare i divari ma, semmai, a renderli più ampi.
|
|
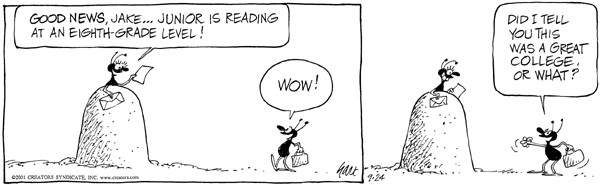 |
http://washingtonpost.com
Lionel Robbins
La
misura del mondo. Breve storia del pensiero economico
Ponte
alle Grazie 2001
pagg.
538 Lit. 40.000 (20.66 euro)
Una storia del pensiero economico scritta da un
grande economista (qui Robbins, ma ricordiamo anche Schumpeter e lo stesso
Marx), comporta il rischio che le interpretazioni dell’autore prevalgano
sulle idee degli economisti del passato. E poiché Robbins è un grande
economista (fra l’altro, in tutti i libri che introducono allo studio della
disciplina è riportata la sua sintetica definizione di economia: “la
scienza che studia la condotta umana come una relazione tra scopi e mezzi
scarsi applicabili ad usi alternativi.”) appare apertamente quando è
d’accordo e quando invece ha delle riserve, che vengono puntualmente
giustificate. Tanto più che il libro in questione si rivolge ad un
pubblico particolare, cioè quello degli studenti della London School
of Economics negli anni accademici 1979-80 e 1980-81 (Robbins è morto nel
1984), sia al terzo anno e quindi non ancora laureati, sia laureati verso il
master.
Le lezioni, raccolte dal nipote allora studente,
mantengono tutta l’immediatezza del discorso, con il rivolgersi direttamente
agli studenti, proponendo letture dirette degli autori, puntualizzando i
passaggi più importanti, mettendo in guardia da errori di interpretazione.
Nella migliore tradizione di una lezione cattedrattica, frontale, che stimola
continuamente l’uditorio presupponendo che non sia costituzionalmente
passivo, ma interessato alle rilevanti questioni che vengono dibattute dagli
economisti citati. Significativa una sua battuta: “In generale, non amo
cominciare le mie lezioni prima che siano passati sei minuti dall’inizio
dell’ora, in parte per via della difficoltà, che ad alcuni di voi tocca, di
passare da un’aula all’altra, in parte perché credo che cinquantacinque
minuti di storia del pensiero economico siano la dose massima che la maggior
parte di voi può assumere in una sola volta.”
Le lezioni partono da lontano, dai ragionamenti di
carattere economico presenti già in Platone e Aristotele, per passare,
attraverso il medioevo, ai preclassici e ai classici. Ampio spazio alla
rivoluzione marginalista, dai tre fondatori a Marshall, con cui le lezioni si
concludono. Nel libro però si riporta anche un intervento a un colloquio tra
economisti russi e britannici tenutosi nel settembre del 1960 alla London
School of Economics, in cui Robbins prosegue il discorso dell’evoluzione
della teoria economica moderna, però non più rivolto agli studenti, ma a
colleghi e per di più provenienti da un paese a economia pianificata. Molto
interessante.
Bisogna precisare che anche le lezioni presuppongono
una qualche conoscenza dei meccanismi della teoria economica e dei passaggi
che all’autore appaiono più evidenti.
sommario
9. LA
DIDATTICA MODULARE NELLE MATERIE ECONOMICHE AZIENDALI E GIURIDICHE
di Lidia Colombo – Diana Collu – Marco Spriano
L’insegnamento
delle materie economiche, aziendali e giuridiche in questi ultimi anni si è
spesso strutturato secondo una logica modulare, con particolare riferimento a
quelle realtà – come quella che noi viviamo – di sperimentazione che
specificamente hanno fatto della didattica modulare il caposaldo dal quale
snodare l’esperienza didattica.
Anche se qui appare necessario circoscrivere il campo
d’indagine alle sole discipline di interesse specifico, sono necessarie
alcune premesse generali, allo scopo di chiarire le potenzialità della
didattica modulare, sempre in relazione allo specifico disciplinare.
Va in primo luogo sottolineato che le discipline
economiche e giuridiche trovano una collocazione, all’interno della
sperimentazione dell’autonomia, sia nel biennio, che nel triennio, in
un’area comune che riconosce alle discipline stesse natura fondante rispetto
al percorso dello studente nel suo complesso: l’area comune consiste infatti
in quel gruppo di discipline che fondano la struttura stessa della
sperimentazione, e che come tali si ritrovano presenti in ogni scuola,
indipendentemente dall’indirizzo seguito.
La collocazione in area comune assume particolare
rilievo non solo in relazione al percorso di biennio, dove ormai appare
esperienza consolidata, ma anche nel triennio, dove invece storicamente
appariva conchiusa ai soli indirizzi tecnico-professionali.
Anche se permane il fossato fra l’esperienza
economico-politica e quella economico-aziendale (che resta collegata ad
un’area specifica d’indirizzo), l’attribuzione delle discipline
giuridico-economiche all’area comune della sperimentazione è segnale
comunque positivo.
In linea generale, possiamo dire che la scelta della
didattica modulare ci ha consentito di ripensare al significato dei contenuti
disciplinari, ai metodi e ai percorsi per giungere agli obiettivi fissati, e
alla certificazione delle competenze acquisite.
A questo punto, il nodo centrale diventa quello di
chiarire le competenze che si vogliono costruire, oltre che i metodi e
percorsi necessari al loro raggiungimento, anche in vista dell’opportunità
di favorire percorsi personalizzati, operando con un lavoro di sostegno per le
situazioni di svantaggio, e con la valorizzazione delle situazioni di
eccellenza che eventualmente emergano.
A questo scopo abbiamo lavorato con forme nuove dal
punto di vista organizzativo, non ritenendo più il gruppo classe come fisso e
immutabile, ma ragionando che fosse possibile lavorare con gruppi eterogenei,
provenienti cioè da classi differenti.
Questo ha richiesto uno sforzo di tipo organizzativo
(orari identici per le classi originarie), ma ci ha anche consentito di
recuperare con forza il lavoro di team come lavoro davvero qualificante della
professionalità docente: il referente del processo didattico diventa
veramente il team, e non solo il singolo docente, perché il processo richiede
che i gruppi così formati siano gruppi stabili, ma a composizione davvero
flessibile, allo scopo di creare e sostenere veramente la motivazione degli
studenti all’apprendimento.
Il modulo appare così davvero un percorso
flessibile, dove vengono salvaguardati anche spazi di approfondimento, che
nello specifico hanno trovato concretezza nell’analisi di piccoli casi
economici a supporto e ampliamento del percorso, per quegli studenti che non
avessero fatto rilevare difficoltà nel corso del modulo.
La scelta di operare con una didattica per classi
eterogenee ha ovviamente comportato il sacrificio di alcuni contenuti
(peraltro non essenziali), ma è stata premiata da risultati positivi in
termini di successo scolastico, senza risultare penalizzante per le situazioni
di eccellenza, per le quali è stato sempre ritagliato un percorso di
approfondimento adeguato, anche in autoapprendimento.
Sostanzialmente, ad una catena per gli alunni in
difficoltà di apprendimento si affianca un catena di valorizzazione delle
eccellenze che emergano nel corso del modulo.
Nello specifico disciplinare, l’intera classe terza
è dedicata al percorso economico, anche con l’intento ideale di dare un
fondamento economico al percorso giuridico (affidato alla classe successiva),
che troppo spesso pare fine a se stesso, e che invece affonda robuste radici
nel mondo dell’economia.
Viene affrontata un’economia politica
essenzialmente microeconomica, con un ultimo modulo forte di macroeconomia.
Questa scelta non vuole essere solo e semplicemente
una resa sul teorico “primato” della micro sulla macroeconomia
(l’attenzione scientifica sul punto è già vasta), ma semplicemente vuole
dare la possibilità di raccordare il percorso politico con quello aziendale.
Dei cinque moduli trattati nel corso dell’anno, i
tre centrali sono essenzialmente microeconomici, e sono preceduti da un lavoro
sugli strumenti matematici dell’economia, e accompagnati per ogni modulo
dall’analisi di casi aziendali, anche in lingua inglese, che consentono un
raccordo fra l’economia politica e l’economia aziendale: questo taglio,
proprio del mondo anglosassone, ha consentito anche la somministrazione di
verifiche sommative in inglese.
Gli studenti che raggiungono i migliori risultati
nella verifica di fine modulo proseguono l’approfondimento, sempre con
un’attenzione al raccordo con l’economia aziendale: gli altri iniziano uno
specifico lavoro di sostegno, allo scopo di recuperare le abilità non
conseguite.
In calce diamo una veloce indicazione del primo
modulo impostato nella classe terza, che consideriamo fondamentale per il
successivo percorso, poiché fonda gli essenziali snodi matematici per
sostenere il percorso successivo: l’analisi dei casi potrà essere
effettuata in classe, preferibilmente con lavori di gruppo e relazioni, nel
corso del modulo stesso, o eventualmente riservando questo lavoro al gruppo di
eccellenza, qualora i tempi non lo consentano.
E’ interessante notare come tutta la bibliografia
citata appartenga al mondo anglosassone, e come anche il libro di testo in
adozione non faccia parte del normale circuito scolastico.
E’strutturato in modo semplice, scientificamente
corretto, con l’utilizzo di esercizi sempre risolti, un linguaggio chiaro, e
un’attenzione ai raccordi con i casi aziendali.
Nella classe quarta viene collocato il percorso
giuridico, che si sostiene anche con i moduli già acquisiti nel biennio sulle
persone, e sugli istituti giuridici regolatori dei rapporti economici, con
particolare riguardo alle obbligazioni.
Il percorso inizia con un modulo sugli strumenti del
diritto, che prevede anche un percorso di laboratorio sul reperimento di norme
e giurisprudenza.
Ogni modulo è sostenuto dall’analisi di due o più
casi giuridici, con studio di legislazione, dottrina e giurisprudenza.
|
PREREQUISITI
|
|
·
Equazioni lineari di primo grado
·
Conoscenza del piano cartesiano
|
|
OBIETTIVI / COMPETENZE
|
UNITA’ DIDATTICHE
|
|
·
Descrive gli strumenti matematici per l’economia
·
Comprende l’utilizzo degli strumenti matematici per
l’economia in relazione a domanda, offerta e prezzo di equilibrio
·
Utilizza gli strumenti matematici per l’economia in
relazione a domanda, offerta e prezzo di equilibrio
|
U.D.1 – L’impiego di strumenti matematici in economia.
U.D.2 – Domanda, offerta ed equilibrio
|
DESCRITTORI DELLE COMPETENZE
U.D. 1
|
DESCRITTORI DELLE COMPETENZE
U.D. 2
|
|
1) Descrive gli strumenti matematici per
l’economia
|
|
·
funzione lineare, inclinazione ed intercetta
·
variabile dipendente e indipendente
·
causa ed effetto
·
variabile omessa ed inversa
·
vincolo “ceteris paribus”
·
tabella, grafico ed equazione
·
derivata
|
·
Funzioni di domanda ed offerta
·
spostamento sulle curve e delle curve di domanda e
offerta
·
effetto reddito ed effetto sostituzione
·
prezzo e quantità di equilibrio.
|
|
2) Comprende l’utilizzo degli strumenti
matematici per l’economia in relazione a domanda, offerta e prezzo di
equilibrio
|
|
·
Comprende la relazione fra tabelle, grafici ed
equazioni
·
Riconosce la valenza del vincolo “ceteris paribus”
·
Individua graficamente una funzione lineare. Risolve
problemi sulle suddette relazioni, anche in riferimento al concetto di
derivata
|
·
Comprende l’utilizzo dello schema “domanda/offerta”
·
Comprende il ruolo del calcolo di equilibrio, e
dell’eccesso di domanda e offerta
·
Riconosce, nell’analisi di casi aziendali, il ruolo
di domanda, offerta e prezzo di equilibrio
|
|
3) Utilizza gli strumenti matematici per
l’economia in relazione a domanda, offerta e prezzo di equilibrio
|
·
Sa rappresentare la funzione lineare
·
Sa applicare la formula di derivazione
|
·
Risolve matematicamente e graficamente problemi di
equilibrio di domanda e offerta
|
|
MATERIALI UTILIZZATI
|
|
·
Salvatore – Diuilio. “Economia”. McGraw – Hill 1997.
Cap.1 e 3 (libro di testo)
·
G.Mankiw. Principi di economia. Zanichelli. 1999.
Appendice al cap.2. pg.30.
·
H.Mabry – H.Ulbrich. Fondamenti di economia politica.
Zanichelli. 1997. pg.92
·
Dowling
Analisi dei
casi: tratti da – E.Mansfield “Economia per il management” Hoepli. 1993.
·
Il crollo dei prezzi della lana nel 1991 – pg.27
·
Diminuzione dei prezzi delle stazioni radio negli
Stati Uniti – pg.29
·
La Walt Disney Production e l’affluenza nei parchi
tematici – pg.82
Analisi dei
casi: tratti da – Nuffield. Economics
& Businnes. Students’ Book. Longman 1994. (Solo per il gruppo che
supera immediatamente il modulo)
|
|
Modalità di lavoro
|
Tipologia di verifiche
|
Tempi
|
|
Lavoro di
gruppo
Intergruppo
Sistematizzazione
con relazioni
|
Strutturate
(al termine di ogni UD – formative)
Semistrutturate
(sommativa)
|
25 ore
|
|
Attività per gruppi di livello
|
|
1. La
prima parte del modulo verrà proposta ai gruppi classe per un totale di 20
ore. Al termine verrà somministrata verifica sommativa per testare il
raggiungimento o meno degli obiettivi, e allo scopo di assegnare gli
studenti, se necessario, ai gruppi di livello.
2. La
seconda parte del modulo verrà proposta a differenti gruppi, formati
sull’esito della predetta verifica, che lavoreranno per un totale di 5 ore.
|
Gruppo che ha superato il modulo
|
Analizza casi
aziendali ulteriori, se possibile anche in lingua inglese.
|
Gruppo che non ha superato il modulo
|
Segue un
percorso di recupero, che viene testato al termine con verifica.
|
|
|
|
|
|
sommario
* * *
SCHEDA
DI ISCRIZIONE AEEE-ITALIA
ADESIONE
2002
|
Quota
individuale
Quota
per scuole, università, associazioni, enti
Socio
sostenitore
|
|
Euro
36,15
Euro
51,64
|
2.
compilare e spedire la seguente scheda di adesione 2000 a:
ELIDE
SORRENTI, VIA BERUTO 7, 20131
MILANO TEL/FAX. 02/2664325
NOME E COGNOME
|
|
|
POSIZIONE
|
|
|
SCUOLA O ENTE DI APPARTENENZA
|
|
|
INDIRIZZO SCUOLA O ENTE
|
|
|
INDIRIZZO ABITAZIONE
|
|
|
TELEFONO: CASA
|
TELEFONO: LAVORO
|
|
FAX
|
E-MAIL
|
|
RINNOVO ASSOCIAZIONE
|
NUOVA ASSOCIAZIONE
|
|
INVIO QUOTA DI ASSOCIAZIONE TRAMITE CONTO CORRENTE
POSTALE
Firma
……………………………………………………………………………………
|
I
dati forniti sono trattati in conformità della L.675/1996 sulla privacy
|
AEEE-ITALIA
c/o CISDCE Centro Internazionale di Studi e di documentazione sulle
Comunità Europee, Corso Magenta 61, 20123 Milano Tel.02/48009072
Fax02/48009067 cisdce@libero.it
|
sommario
Cfr. Mario Pinotti , Per una fondazione
culturale di un curricolo delle competenze, pagg.20-21, in
"Curricoli per la scuola dell'autonomia" a cura di Adriano
Colombo, Rossella D'alfonso, Mario Pinotti, La Nuova Italia - Progettare la
scuola, febbraio 2001.